
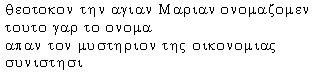
Giovanni
Damasceno
De Fide Orthodoxa 1, XII pg94, 1028
Theotokos - Ricerche
Interdisciplinari di Mariologia
(1996/1)
151-188
|
|
Theotokos - Ricerche
Interdisciplinari di Mariologia |
|
“Tutto ciò avvenne perché si adempisse quanto era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 'Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà chiamato Emmanuele, che significa Dio con noi” (M t 1,20-23). La citazione di Is 7,14 all 'inizio del Vangelo di Matteo spiega l’ importanza che il testo isaiano ha sempre avuto all'interno della teologia e della predicazione ecclesiale. Quando nella cultura cristiana del mondo occidentale si perse il contatto con il dinamismo della tradizione che sta alla base della formazione stessa della Scrittura, venne anche meno la possibilità di comprendere la ricca prospettiva e la profonda intenzionalità nella quale si sviluppavano i richiami alla Parola di Dio e le citazioni esplicite dei testi biblici. Si venne così formando l'idea che i profeti erano uomini che, secoli prima, avevano predetto sia la venuta di Gesù di Nazaret, sia i particolari più significativi della sua missione e, soprattutto, della sua passione e morte. Questa concezione favorì un approccio "apologetico" ai testi biblici con l'intento di provare il compimento di singole profezie nelle parole e nelle azioni di Gesù. In questo modo non solo venne a mancare un approccio al messaggio della Scrittura colto nella sua specificità storica ed esistenziale, ma si smarrì anche la coscienza del processo dinamico e fecondo che accompagnò la genesi della Scrittura e la sua continua attualizzazione nella tradizione viva e pneumatica del popolo del Signore. Le varie metodologie scientifiche sviluppate nell’esegesi biblica, l' attenzione alle letterature coeve dell' Antico Oriente e, in particolare, lo studio delle testimonianze targumiche e rabbiniche hanno consentito di superare questa mentalità e di riscoprire la vitalità della tradizione dell' A.T. La via da percorrere in questa direzione è senza dubbio ancora lunga, però è già possibile ricuperare alcune prospettive che si rivelano fondamentali per la comprensione del Nuovo Testamento e, quindi, per il rinnovamento stesso della teologia, chiamata dal Vaticano Il a riscoprire se stessa, la propria anima, nella Scrittura. Il presente contributo analizza anzitutto la promessa di Is 7,1-17 e quindi si propone di seguire le tappe più significative dell’influsso che questa promessa esercitò all'interno dell' A.T. Ogni tappa di questo sviluppo rappresenta un nuovo livello di approfondimento della promessa, in altri termini esprime una reinterpretazione che, a sua volta, attira a se altri temi e costituisce la premessa per un'ulteriore crescita della tradizione stessa. Come si desume dalla prospettiva delineata, non è nostro compito addentrarci nello studio dell'influsso esercitato da Is 7 all'interno del N.T. o nell'esegesi di Mt 1,20-23. La conoscenza della tradizione dell'Emmanuele, però, consentirà di intravedere la concezione profonda sottesa all'interpretazione "cristologica" sviluppata dagli autori del N.T. In questa visuale sarà anche possibile intuire la fecondità delle prospettive che l' approccio al N.T. dischiude alla teologia, quando esso si verifica rispettando la profonda sintonia degli scritti neotestamentari con le grandi tradizioni della Scrittura e individuando il significato della loro reinterpretazione sviluppata alla luce della fede nel Signore risorto. Il nostro studio, in particolare, mostrerà che la conoscenza della tradizione di Is 7 permette di determinare meglio la prospettiva con cui la riflessione cristologica delle comunità protocristiane ha colto la funzione di Maria, "madre di Gesù", compresa nella sua realtà di primizia e icona della Chiesa, popolo della risurrezione e, quindi, della nuova creazione che realizza l' alleanza eterna dell'umanità con il Dio santo [1]. |